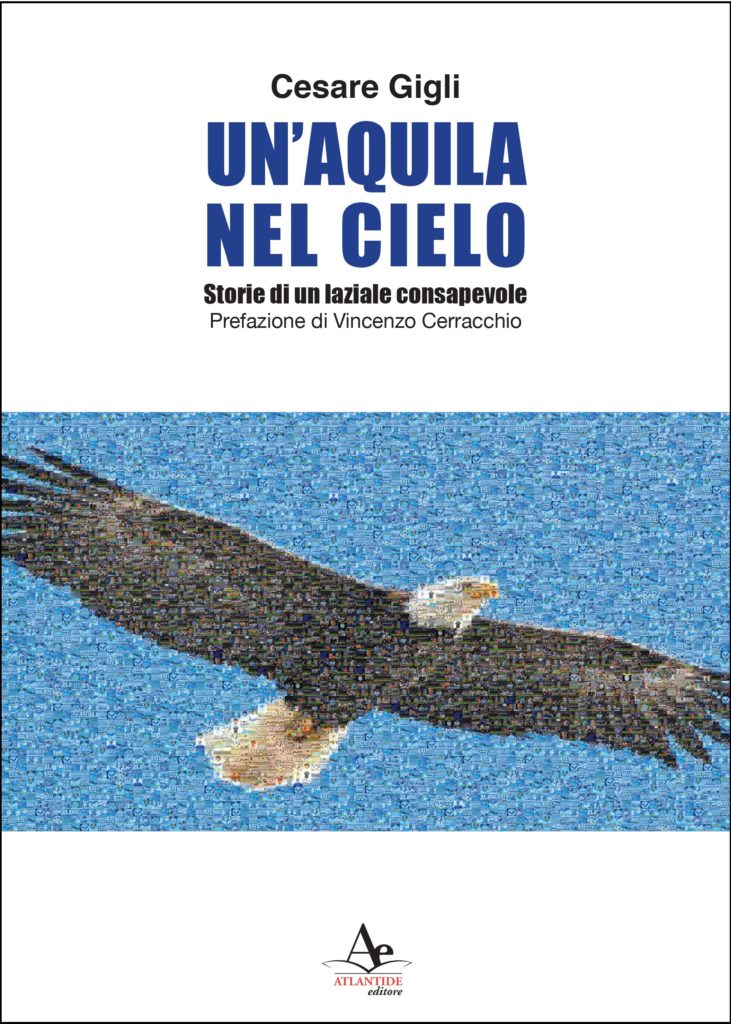Nulla come quella Coppa Italia rappresenta lo spirito del laziale. Le due semifinali contro la Juve, che stava vincendo il suo secondo scudetto consecutivo con agilità, furono un concentrato di emozioni.
[…] Un sottile senso di angoscia si stava impossessando di parecchi biancocelesti. La paura di incontrare la Roma era palpabile e quando ad aprile quella possibilità divenne reale, l’angoscia, da sottile, si fece pesantissima. La mentalità del laziale è questa, c’è poco da fare. Non pensa a quanto sarebbe bella la vittoria, ma a quanto sia devastante la sconfitta. So per certo che in tanti si rintanarono in casa, quel 26 maggio, per non vedere e non sentire.
Scelsi di vederla con Giorgio, amico di mille partite e di centinaia di discussioni. Andare allo stadio, come per tutti i derby, era escluso. Ci mettemmo seduti sul divano di casa sua a mani giunte (non proprio in segno di preghiera, diciamo un poco più in basso) per tutti i novanta minuti.
Quando Lulic segnò al 71’ neanche esultammo: era un’emozione troppo grande per poterla esprimere in qualche maniera. Era tutta interiore. Continuammo a vedere quegli eterni venti minuti sempre a mani «giunte», come sopra. Solo al fischio finale dell’arbitro Orsato ci abbracciammo, e cominciammo a sorridere, e poi a ridere. Ma a ridere tanto, di una gioia reale. Avevamo vinto il primo derby, e fino adesso l’ultimo, con qualcosa in palio.
Decidemmo di andare a mangiare nella trattoria di un nostro caro amico, romanista. A questo punto, potevamo permetterci tutto. Lui, da gran signore, ci accolse accettando lo sfottò, e anzi rincarò la dose: «Potete ordinare tutto ma non il fegato. Oggi me lo sò magnato io».